 Su Liberazione del 16 novembre un intervento di Nichi Vendola
Su Liberazione del 16 novembre un intervento di Nichi VendolaPredichiamo il cambiamento ma il cambiamento non ci riconosce
Sarebbe bello poter compiere il nostro cammino dentro gli snodi delle odierne contraddizioni, facendo vivere un confronto aperto e coraggioso, una ricerca collettiva sulla traccia di lavoro che ci ha proposto su questo giornale Fausto Bertinotti. Rischiamo non solo di separarci tra noi, ma tutti noi, comunque collocati, rischiamo di separarci dal mondo, rischiamo di vivere lo spazio asfittico delle fissità politico-ideologiche senza più intendere il rumore e il senso di quel cambiamento che torna a scaldare i motori. Rischiamo di essere travolti persino dall’onda anomala che aspettavamo: dalle viscere della crisi della globalizzazione, dai luoghi frammentati e minacciati della formazione e della produzione, dalle crepe nella gerarchia dei poteri e dei valori, sgorgano rivolte nuove, protagonisti territoriali o tematici, linguaggi critici che sono quella “domanda sociale” di una sinistra che invece fatica a incarnarsi, che cerca di reclutare piuttosto che di capire e interloquire. Di questa sinistra che appare muta, muta perché priva di parole, orfana di vocabolario, capace solo di citarsi addosso. Non siamo personaggi in cerca d’autore: anzi, gli autori abbondano. Semplicemente non abbiamo più un teatro, il teatro. A meno che non si pensi che, con un po’ di restauri, copione e proscenio si rimettono a posto e siamo pronti per recitare una qualche rivoluzione. Il teatro del Novecento è stato raso al suolo.
La lotta di classe, il lavoro come principio di significazione sociale, la religione civile dell’antifascismo, l’auto-narrazione di un Paese immerso nelle acque di un Mediterraneo accogliente e plurale: tutto è entrato in una sorta di centrifuga storica, la memoria s’è mutata in fiction e caos pubblicitario, i corpi sociali si sono dispersi in mille rovinosi esodi dalla socialità e dall’impegno, il capitalismo ha aderito come una seconda pelle all’antropologia del post-moderno: capitalismo della finanziarizzazione, con i suoi mulini a petrolio che impastavano la farina del diavolo (il denaro e la guerra). Il comunismo delle oligarchie uccideva con i carriarmati la speranza planetaria del comunismo: l’Est rovinava come un castello di carta e senza troppi rimpianti. Spostamenti di punti cardinali (e di sogni popolari e di idee-forza) disegnavano una inedita geo-politica: e dentro questo nuovo e oscuro mappamondo, il lavoro veniva perdendo potere e valore, il suo novecentesco “assalto al cielo” si concludeva con uno schianto. Il profitto come paradigma di regolazione sociale si gloriava del suo carburante malato: il denaro ebbro della speculazione e del gioco d’azzardo. Ecco, avanzava il ciclo della produzione di “denaro a mezzo di denaro”, e il possedere, la patrimonializzazione della vita, il consumo predatorio, diventavano nodi psichici, contenuto delle relazioni tra le persone. E le nostre comunità si sono smarrite, disperdendosi nella dipendenza da merce effimera, ma talvolta rattrappendosi in forme comunitarie primitive, nevrotiche, direi modernamente tribali. Questo non ha ferito a morte la domanda di cambiamento, ha però colpito la radice delle risposte conosciute, ha travolto lo “stile” del cambiamento: siamo a cavallo di uno strano paradosso, noi predichiamo il cambiamento ma il cambiamento non ci riconosce, anzi ci scansa. Se crediamo di cavalcare la tigre ci illudiamo: prenderemo morsi, saremo subito disarcionati. Il mondo cambia a dispetto della nostra consueta depressione. Siamo noi che rischiamo di non cambiare: non sto pensando all’euforia del trasformismo, ai tanti cedimento alle lusinghe del potere, ma a una cultura politica che si libera dai paraocchi, che osserva con radicale schiettezza le cose della realtà, che si misura con i movimenti reali e con una devastante crisi di civiltà. La sinistra che è stata lungamente spogliata di identità e orgoglio, ma anche quella che è stata imbottita di pillole di anabolizzante identitarismo. Come ricominciare? questo rovello potremmo viverlo con intensità morale e intellettuale, piuttosto che usarlo come corpo contundente gli uni con gli altri, le une con le altre. La dimensione europea, anche in vista dell’appuntamento elettorale, può essere l’asse portante del pensare e dell’agire politico di una sinistra capace di parlare ai popoli e alle giovani generazioni: si può mettere questo al centro delle scelte necessarie a ridare fiato complessivamente alle forze della sinistra? Io credo che l’associazione per la sinistra possa rappresentare un luogo di ri-tessitura di relazioni socialmente e culturalmente necessarie a far vivere il “senso” della parola sinistra. Non è la sincerità della nostra passione che ci accredita come timonieri esperti del buon cambiamento: la gente non ti conosce, il corpo produttivo non capisce che tu lo difendi, la gioventù addirittura ti rimprovera un certo odore di naftalina. Bisogna avere l’umiltà e l’ardire di restituire un senso materiale alla trinità laica del “libertà/fraternità/eguaglianza”: qui, in questo punto della crisi che divora l’acqua e la terra, in quella teoria di crepe che succhiano il sangue dei produttori, in questa guerra naturalizzata ed eterna, qui il fischio del cambiamento torna a riecheggiare. Vorrei che imparassimo ad ascoltare quel fischio, e la smettessimo di vendere fischietti.
La lotta di classe, il lavoro come principio di significazione sociale, la religione civile dell’antifascismo, l’auto-narrazione di un Paese immerso nelle acque di un Mediterraneo accogliente e plurale: tutto è entrato in una sorta di centrifuga storica, la memoria s’è mutata in fiction e caos pubblicitario, i corpi sociali si sono dispersi in mille rovinosi esodi dalla socialità e dall’impegno, il capitalismo ha aderito come una seconda pelle all’antropologia del post-moderno: capitalismo della finanziarizzazione, con i suoi mulini a petrolio che impastavano la farina del diavolo (il denaro e la guerra). Il comunismo delle oligarchie uccideva con i carriarmati la speranza planetaria del comunismo: l’Est rovinava come un castello di carta e senza troppi rimpianti. Spostamenti di punti cardinali (e di sogni popolari e di idee-forza) disegnavano una inedita geo-politica: e dentro questo nuovo e oscuro mappamondo, il lavoro veniva perdendo potere e valore, il suo novecentesco “assalto al cielo” si concludeva con uno schianto. Il profitto come paradigma di regolazione sociale si gloriava del suo carburante malato: il denaro ebbro della speculazione e del gioco d’azzardo. Ecco, avanzava il ciclo della produzione di “denaro a mezzo di denaro”, e il possedere, la patrimonializzazione della vita, il consumo predatorio, diventavano nodi psichici, contenuto delle relazioni tra le persone. E le nostre comunità si sono smarrite, disperdendosi nella dipendenza da merce effimera, ma talvolta rattrappendosi in forme comunitarie primitive, nevrotiche, direi modernamente tribali. Questo non ha ferito a morte la domanda di cambiamento, ha però colpito la radice delle risposte conosciute, ha travolto lo “stile” del cambiamento: siamo a cavallo di uno strano paradosso, noi predichiamo il cambiamento ma il cambiamento non ci riconosce, anzi ci scansa. Se crediamo di cavalcare la tigre ci illudiamo: prenderemo morsi, saremo subito disarcionati. Il mondo cambia a dispetto della nostra consueta depressione. Siamo noi che rischiamo di non cambiare: non sto pensando all’euforia del trasformismo, ai tanti cedimento alle lusinghe del potere, ma a una cultura politica che si libera dai paraocchi, che osserva con radicale schiettezza le cose della realtà, che si misura con i movimenti reali e con una devastante crisi di civiltà. La sinistra che è stata lungamente spogliata di identità e orgoglio, ma anche quella che è stata imbottita di pillole di anabolizzante identitarismo. Come ricominciare? questo rovello potremmo viverlo con intensità morale e intellettuale, piuttosto che usarlo come corpo contundente gli uni con gli altri, le une con le altre. La dimensione europea, anche in vista dell’appuntamento elettorale, può essere l’asse portante del pensare e dell’agire politico di una sinistra capace di parlare ai popoli e alle giovani generazioni: si può mettere questo al centro delle scelte necessarie a ridare fiato complessivamente alle forze della sinistra? Io credo che l’associazione per la sinistra possa rappresentare un luogo di ri-tessitura di relazioni socialmente e culturalmente necessarie a far vivere il “senso” della parola sinistra. Non è la sincerità della nostra passione che ci accredita come timonieri esperti del buon cambiamento: la gente non ti conosce, il corpo produttivo non capisce che tu lo difendi, la gioventù addirittura ti rimprovera un certo odore di naftalina. Bisogna avere l’umiltà e l’ardire di restituire un senso materiale alla trinità laica del “libertà/fraternità/eguaglianza”: qui, in questo punto della crisi che divora l’acqua e la terra, in quella teoria di crepe che succhiano il sangue dei produttori, in questa guerra naturalizzata ed eterna, qui il fischio del cambiamento torna a riecheggiare. Vorrei che imparassimo ad ascoltare quel fischio, e la smettessimo di vendere fischietti.

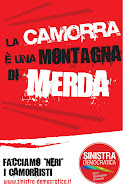





Nessun commento:
Posta un commento